Ordine e sicurezza: parole oggi divenute fondamentali nella definizione di uno stato prospero, capace di garantire coesione e benessere sociale. Ma chi propone questi due elementi come prioritari nel raggiungimento della condizione sociale sopracitata, ha ragione? Un approccio cinico e superficiale suggerirebbe una risposta affermativa. Un’analisi sociologica metterebbe in luce la terribile complessità di tale quesito.
Il sistema carcerario è stato soggetto ovunque ad una crescita esorbitante negli ultimi decenni e sempre più ampi settori della popolazione sono considerati una minaccia per l’ordine sociale. Il numero di persone in detenzione cresce in quasi tutti i paesi e si sta assistendo ad un boom di costruzioni detentive in tutto il mondo. Perfino in Norvegia, paese particolarmente restio a comminare pene detentive, la percentuale di reclusi è salita da meno di 40 unità per 100.000 abitanti nei primi anni Settanta ai 64 per 100.000 dei nostri giorni. Negli Stati Uniti, patria di democrazia e libertà, il 2% della popolazione totale è soggetta al controllo del sistema penale e oltre un quarto degli uomini afroamericani è in carcere o ai domiciliari. Nel 2008, 2,3 milioni dei 9,8 milioni di detenuti in tutto il mondo erano reclusi nelle prigioni americane e circa il 60% di quelli statunitensi è stato condannato per reati non violenti legati alla droga. Come si spiega la propensione da parte degli stati moderni di espandere le proprie capacità punitive alimentando la convinzione che il pilastro portante della giustizia sia costituito da una sempre più rigido utilizzo del sistema penale? Come afferma il criminologo norvegese Nils Christie, la nostra società moderna tende ad attribuire “caratteri criminosi” a “una quantità sempre maggiore di atti considerati negativi” e “un numero sempre maggiore di questi atti ha come effetto la carcerazione”. Tale teoria premette un’individuazione della criminalità basata sulla definizione da parte dell’opinione pubblica di ciò che è criminoso: è deviante ciò che viene definito tale. E appare evidente come nell’atto di definire la criminalità svolga un ruolo centrale la classe politica, i cui sceneggiatori tendono a rappresentare il mondo come suddiviso tra criminali e custodi dell’ordine. Di conseguenza la vita umana naviga nella stretta gola tra la minaccia di subire violenza e la necessità di attaccare chi potenzialmente porta l’attacco. Quale più semplice ed elementare metodo possono adottare i governi per divincolarsi dalle proprie responsabilità ed incapacità di risolvere problemi irrisolvibili? Probabilmente nessuno. D’altronde tale pratica giova fortemente alla classe politica al governo nella misura in cui essa dimostra che “sta facendo qualcosa” per alleviare le preoccupazioni della gente. Preoccupazioni rese fondate da quotidiani documentari e drammi, documentari raccontati in forma drammatica e drammi accuratamente travestiti da documentari. Costruire nuove prigioni, emanare nuove norme che moltiplicano le infrazioni da punire con la detenzione ed allungare le pene sono tutte misure che rendono i governi agli occhi della popolazione determinati a sradicare le cause di ansie e paure diffuse. La lotta al crimine diventa uno spettacolo eccitante, e la sua spettacolarità conta più della sua efficacia. L’effetto complessivo è che la paura cresce di continuo.
Sigmund Freud aveva suggerito come nel periodo “classico” dell’età moderna le afflizioni e sofferenze psicologiche fossero scaturite dall’atto con cui si cedeva una parte della propria libertà personale in cambio di una certa misura di sicurezza garantita dalla collettività. Zygmunt Bauman ne Il disagio della postmodernità, sostenne che oggi si sta verificando il contrario: a generare sentimenti diffusi di ansia e paura è proprio l’inclinazione a rinunciare ad una quota molto elevata di sicurezza della propria persona per rimuovere sempre più vincoli che limitano l’esercizio della libera scelta. A minacciare le condizioni di sicurezza dei singoli individui è l’incertezza e l’indeterminatezza del mondo postmoderno. La crescente mancanza di regole del gioco nell’interazione sociale tenta tutti noi a rifugiarci nella sicurezza che offre la territorialità. Dunque la “difesa del territorio” e la “casa sicura” diventano le parole d’ordine. Intorno alla ricerca di una condizione di sicurezza si accumulano moltissime tensioni. E dove si manifestano tensioni, brillanti investitori ed abili raccattatori di consenso elettorale intravedono capitale politico. Tuttavia nella sua solidità di mattoni e calce, la “casa” diventa una prigione se qualcuno ci chiude in essa dall’esterno. E in un momento storico in cui la mobilità appare così semplice da rappresentare lo strumento garante della libertà personale, il divieto di muoversi simbolizza la forma estrema di impotenza, di perdita di facoltà, di pena. Non c’è da meravigliarsi dunque se la condanna alla detenzione sia considerata il metodo più efficacie per neutralizzare ed escludere persone potenzialmente pericolose. È a questo punto del ragionamento che appare evidente come l’obiettivo fondante dell’istituzione giudiziaria sia venuto meno a causa dell’incapacità e degli interessi miopi dei suoi stessi fautori e teorizzatori. In questo senso Donald Clemmer coniò nel 1940 il termine “prigionizzazione” per identificare i reali effetti della detenzione, nettamente diversi da quelli di “rieducazione” e “riabilitazione”. Nella società postmoderna, l’intento che si cela dietro la condanna al carcere è segregare gli individui pericolosi e rendere la loro devianza innocua per la salvaguardia dell’ordine sociale. L’intero processo giudiziario è un rituale simbolico di rifiuto e di esclusione, e lo stesso diritto concesso all’imputato di potersi difendere mette in luce un’enorme contraddizione: difendendosi, il reietto, in un certo senso, rifiuta chi lo rifiuta, attribuendosi i tratti del criminale per definizione, del recidivo, di chi rifiuta attraverso il solo mezzo a sua disposizione decisioni prese dall’autorità giudiziaria e dunque giustamente condannato. Come ripercussione, i reclusi vengono risucchiati all’interno di una “cultura della prigione” che li rende ancora meno adatti di prima alla vita al di fuori del carcere e meno capaci di seguire le regole e gli usi della vita sociale. Il carcere diventa lo strumento principale di una profezia che non può non avverarsi, elemento fondamentale nella produzione sociale del crimine. La prigione è una scuola di criminalità.
FONTI:
Anthony Giddens Elementi di sociologia
Zigmunt Bauman Dentro la globalizzazione
Zigmunt Bauman Il disagio della postmodernità
Donald Clemmer The prison community
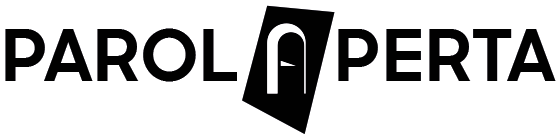





Una risposta