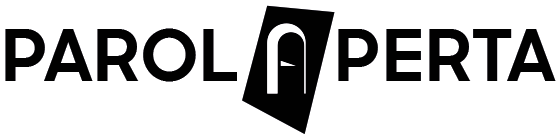Parto di scatto a scrivere questo articolo, vittima – in un certo senso – della medesima “comodità” della quale voglio trattare qui, in una calda serata di maggio. Foglio word bianco, con il titolo a fissarmi ma con una pigrizia paradossale che, per qualche minuto, mi ha allontanato dal battere i tasti su quello che è un argomento davvero scomodo: la comodità.
Questa riflessione parte per telefono (ironia della sorte), parlando con un caro amico della mia ultima attività pubblica. Chi mi conosce sa che amo la politica come amo mangiare la qualunque e, in una certa terminologia dispregiativa, questo connubio è pure validissimo. Parentesi a parte, mi viene chiesto “ma ce n’era gente?” e io rispondo “tenendo conto della poca pubblicità, della tematica delicata e dell’orario, devo dire di sì”. Da qui, l’idea che forse le iniziative pubbliche, i comizi, i convegni, stiano perdendo quel fascino di un tempo, se non la propria utilità concettuale. Alzarsi e andare ad ascoltare cos’abbia da dire “quello là” di turno appare, nel concreto, inutile nel momento in cui il medesimo pensiero può essere ascoltato e rivisto su Facebook, da casa. A che serve, allora, “avere gente” davanti mentre parli? È davvero così importante se ciò che dici arriva comunque?
Da queste domande ho iniziato a capire che effettivamente noi uomini siamo attirati, forse più che dalla materialità delle cose, da un elemento assai pernicioso e per certi versi astratto: la comodità; e dal 2020, tra una mascherina e l’altra, questa condizione si è soppiantata dentro ognuno di noi, chi più chi meno. Se prima, infatti, in casa ci si stava per motivi precauzionali e di sicurezza pubblica, adesso invece senza pensarci due volte, con livelli di stress considerevoli dopo aver passato neanche mezza giornata a contatto con qualcuno. Vogliamo i nostri spazi. Le nostre comodità. Si tratta di una trappola, quella dell’essere comodi, che porta l’uomo ad accettare qualunque cosa, a preferire il sonno al sogno; tutto, pur di fare con il massimo agio ciò che stiamo facendo o che dovremmo fare. È così che la DAD, checché se ne dica, piace tanto: si sta con il pigiama, telecamera spenta, e il risultato lo si raggiunge comunque. È così che Amazon ha la meglio sul giro in libreria: perché uscire, correre il rischio che quel libro neanche ci sia, quando in due giorni può arrivare sotto casa? Perché ricordare quando sia nato Napoleone, se Alexa, Google o Siri hanno già la risposta se urliamo il loro nome? E ascoltando alcune persone, in stato di disarmante lucidità, si è diventati comodi persino nel sesso: “lei deve muoversi, io già lo devo mantenere” o “deve fare tutto lui basta che finiamo”. Comodi e accomodanti. E ragazzi, se lo si è diventati anche sotto le lenzuola, si è veramente messi male.
Tutto ciò, ironia a parte, è disumanizzante. Altro termine non lo trovo. Talvolta mi guardo intorno e noto un’aridità del cogito e del facere senza precedenti. Ho citato Alexa prima, ma voglio ricordare un’abitudine di mio padre. Lui, imperterrito, fino al 2015 girava con l’agendina telefonica in tasca, insieme ad un’inseparabile bic nera. Poi gli passai il mio Galaxy quando io presi il telefono nuovo. Perse quell’abitudine che invece io non ebbi mai. Il risultato è che adesso non ricordiamo un cazzo, se non il nostro numero, e a malapena. Perché “tanto è in rubrica”. Non si è più abituati a ricordare, a tenere allenata la mente. Non si è abituati – lato sensu – a reagire, semplicemente perché vi è la pigrizia di trovare un motivo per farlo o, peggio ancora, perché sembra andare tutto bene, quindi perché scomodarsi? È proprio questo agio che fa beare della propria inettitudine, facendo sentire arrivati quando in realtà non ci si è nemmeno allacciati le scarpe per correre. D’altronde, è nei momenti difficili che l’uomo ha dato il meglio di sé. Basti pensare al ‘500, quando l’Italia assisteva alla corruzione del papato, a guerre fratricide, faide interne, invasioni dall’estero e ciononostante, quello stesso territorio in quel periodo storico ha partorito talenti come Ariosto, Tasso, Michelangelo, Raffaello, Leonardo e via discorrendo.
Eppure, oggi, di “momenti difficili” ne abbiamo un’infinità, e siamo abbastanza connessi da conoscere anche quelli lontani chilometri da noi. Crisi climatiche, guerre, pandemie, diseguaglianze sociali, segnano difficoltà certamente non basilari. Seguendo la logica e la storia antecedente, però, dovremmo avere abbastanza stimoli da avviare una belle époque 2.0. E invece – a meno che non tocchi direttamente – sembra che più agio si abbia e meno si faccia, contrariamente alla retorica difensiva del “se avessi, farei”. D’altronde, si pensa troppo facilmente che quell’agio sia dovuto, che se ne abbia diritto ad averlo. Giulietto Chiesa, a tal proposito, ci aveva visto lungo: “oggi viviamo in un mondo in cui la gente crede di avere solo diritti, dimenticando di avere anche dei doveri”. È così che si crede di avere diritto al benessere, senza tener conto del certo dovere che si dovrebbe esercitare nel tenerlo. Inevitabilmente, però, è il sacrificio che dà valore alle cose, come d’altronde ne è l’etimologia medesima: sacrificare significa “fare-sacro”. Ebbene, che qualcosa la si renda “sacra”.
Si riprenda il gusto di parlare, si riscopra la felicità nel guardare negli occhi chi ti parla, anziché da dietro la cam. Si recuperi la voglia di prenotare in pizzeria e mangiare tutti insieme, anziché ordinare su Just Eat. Si riscopra la magia di invitare ad un caffè fuori con il genuino pretesto di parlare. Si vada al cinema, con le dita tra i popcorn che si incrociano con quelle dell’altro. E magari dopo, saliti a casa, che scompaia pure quella comodità tra i corpi.